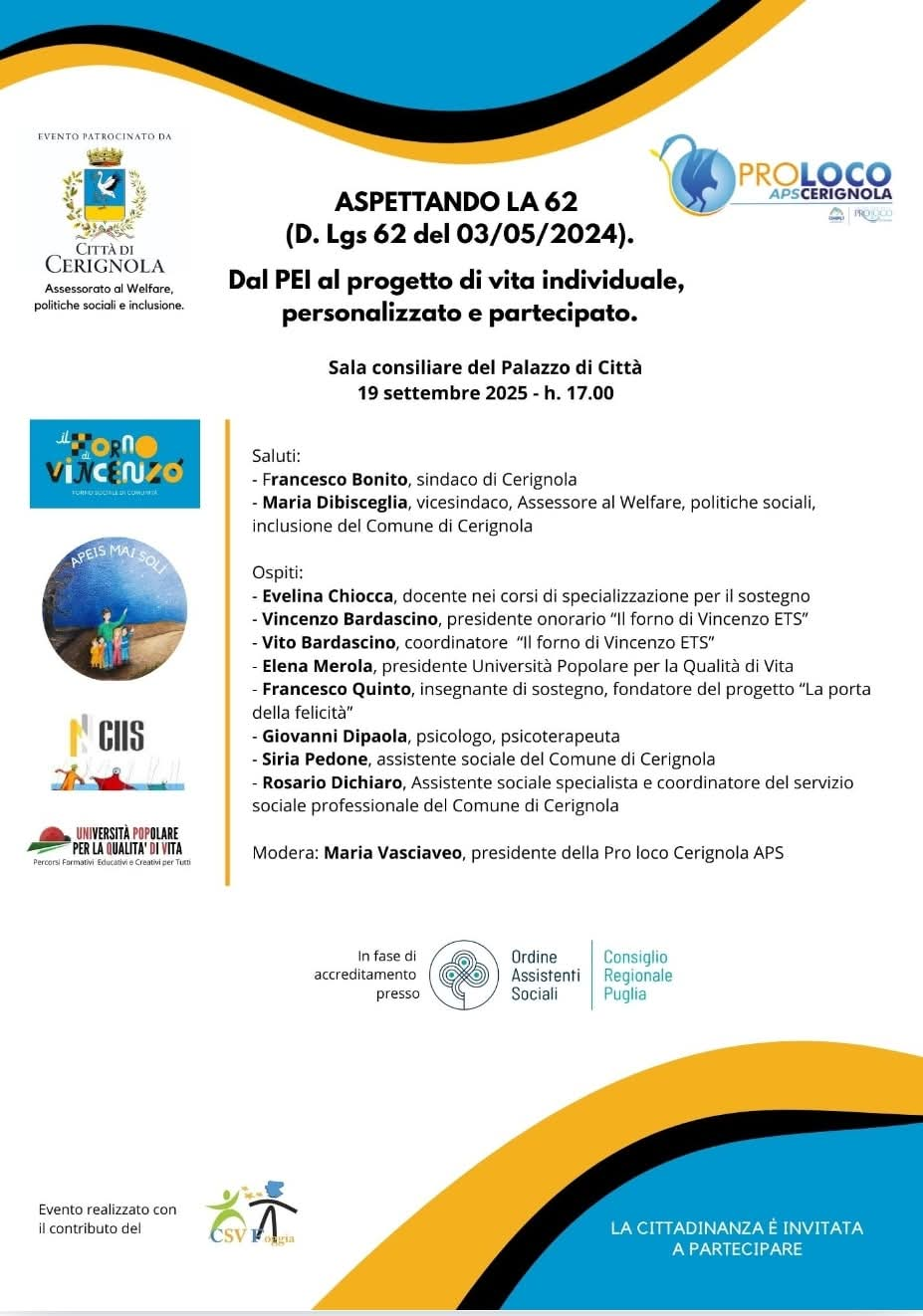Facciamo un gioco: proviamo a chiudere gli occhi e torniamo per un attimo bambini, quando ci siamo avvicinati per la prima volta al campo di calcio sotto casa, ad esempio. Cosa e chi avremmo voluto incontrare? Troveremo spazi e momenti precisi, sensazioni ed emozioni correlate.
Qualcuno si sentirà spaesato, altri troveranno coraggio o fuggiranno difronte ai pericoli.
Incontreremo rumori, odori di cucina, automobili utili per esercitare tackle improbabili solo per recuperare il pallone incastrato tra ruote e marmitte, balconi da evitare per non prendersi un bel gavettone di acqua sporca. Sicuramente ci divertivamo perché c’erano dei pericoli.
Sicuramente, nella voglia di divertirci con gli amichetti di allora, abbiamo mostrato curiosità verso quel tanto caro pallone da gioco, a metà tra un feticcio ed un oggetto interno da venerare.
Ed è proprio grazie alla curiosità che abbiamo potuto gettare, inconsapevolmente, le basi per la consapevolezza del nostro sé, capace di aiutarci a pensare, scegliere, decidere.
Va bene tutto, però, come favorire il concetto di curiosità in età evolutiva?
In uno studio condotto da Kashdan e Silvia (2009), la curiosità diviene concetto fondamentale per la motivazione interna e per la conseguente volontà degli individui a espandere la loro conoscenza, le loro abilità e il loro senso di sé. E non è un caso se anche per questa ragione l’obiettivo dello sport giovanile resta quello di rendere consapevole ciò che non è, riprendendo il concetto di affordance (Gibson, 1979). Perché se da un lato diverrà indispensabile per gli addetti ai lavori porre l’accento sulla consapevolezza dei gesti motori, d’altro canto risulterà determinante la capacità di rendere trasferibile questi aspetti in termini socio relazionali.
Semplicemente, perché è la formazione l'unica cosa che conta.
In una società civile di tipo iper, dove manca, però quel background di strada da cui spesso proviene la pratica sportiva, come possiamo osservare questo prezioso concetto da un punto di vista sociale? La cara vecchia educazione socioaffettiva, ad esempio, metodo educativo di sviluppo della conoscenza di sé e delle proprie emozioni, sembra suggerirlo ad alta voce vista la sua capacità di migliorare l’esperienza individuale all’interno dei gruppi sociali.
Essendo finalizzata a migliorare le comunicazioni e le interazioni tra le parti al fine di contrastare disagi giovanili di diverso tipo, permetterà di orientarsi a quel senso di autonomia rappresentato dall’educazione stessa. Proprio per questa ragione, si diventerà giovani adulti, liberi e responsabili, solo a seguito di un lungo processo che riguarda l’area delle competenze non solo cognitive ma anche emotive, affettive e socio-relazionali. E allora, visto che per divertirci ci bastava cercare gli altri in una piazzetta o al massimo bussando o citofonando a casa, come possiamo ricreare un contesto quanto più simile? E magari, nell’attesa, ripetendo i gesti sportivi anziché scrollare uno schermo?
Quindi, in che modo, attraverso la pratica sportiva, l’individuo può conoscere e sviluppare il concetto di responsabilità? E cosa rappresenterà, per ciascuno, il concetto di inclusione?
Sappiamo bene quanto sia deleteria una società basata sulla prestazione, specie se tale costrutto sia presente dalla tenera età.
Dover essere sempre al primo posto a discapito di chiunque e sopra ogni cosa.
Tutto ciò non può orientarci all’inclusione.
Tutto ciò non consentirà di formare le generazioni future.
Cominciamo a distinguere i concetti di competizione e prestazione.
E magari a ricordarsi di come sia indispensabile parlare di generosità quando affrontiamo temi, appunto, generazionali.
La generazione Z di cosa avrà bisogno? Quali sono i suoi valori? Siamo gli adulti che avremmo voluto ascoltare da bambini, oppure siamo presi solamente dai numeri da dimostrare al mondo adulto? Stiamo offrendo un servizio ed un’esperienza globale in quanto agenzia educativa o stiamo vendendo un mero prodotto da ottimizzare con fumo negli occhi?
Al netto dei quesiti, il nostro pensiero deve rivolgersi a quel cervello rettiliano indicato da MacLean (1984), sede degli istinti primari in termini spazio-temporali come della difesa del territorio e delle risposte di attacco-fuga, e che strizza l’occhio al sistema limbico, sede dell’emotività e al processo decisionale, indispensabile per rendere efficace qualsiasi cosa attraverso l’esperienza.
Questo concetto è decisivo per migrare dall’idea di curiosità a quello di scoperta.
E il compito degli addetti ai lavori sarà senza dubbio quello di renderlo quanto più consapevole, ossia favorire nell’individuo la capacità di essere a conoscenza di quello che succede.
Una conoscenza che posso allenare attraverso situazioni reali e simili a quelle della competizione, dove posso integrare ed incontrare le emozioni che si provano, parafrasando De André, difronte “ad un uomo dello stesso e identico umore ma con la divisa di un altro colore”.
In questo modo, e soprattutto con questo compito preciso da raggiungere, potremo chiederci, ad esempio, non solo come comunicare con il bambino che è dentro di noi ma soprattutto come collegare il sistema limbico di entrambi, capace di mettere in condivisione il mondo emotivo di entrambi nella relazione allenatore-bambino. Questo passaggio sarà fondamentale per il bambino, al fine di riconoscere la propria esistenza e favorire il processo di costruzione della propria identità, e per l’allenatore, al fine di scardinare il proprio ruolo in termini emotivi e osservare il gioco con gli occhi del bambino e dell’adulto che avrebbe voluto avere accanto. La curiosità, dunque, diviene non solo porta di accesso della consapevolezza ma chiave di accesso per scoprire il mondo interno dell’altro.
La lotta primitiva e rettiliana, nonché l’unica partita vera da vincere, sarà una solamente, semplice più che mai: quella tra dopamina e cortisolo. Ossia tra generare il piacere di fare le cose oppure ostacolarlo. E’ il derby dei derby, un superclasico immancabile, un old firm d’altri tempi.
Perché in questa lotta antica ed eterna, si determina la nostra memoria ma soprattutto le nostre decisioni in quanto atti emotivi. E di conseguenza, saranno comprese anche le nostre responsabilità. Da che parte scelgo di stare?
Chi si cerca si diverte…perché ha piacere di farlo.
Ed ognuno ha piacere di farlo per i suoi sacrosanti motivi e con i suoi tempi: la soggettività è tutto.
Servirà coraggio, ossia quell’azione del cuore avente sede nell’altro lato della stessa medaglia in cui risiede la paura. E servirà anche quest’ultima, purché ci conduca al desiderio.